Per chi a distanza di oltre 80 anni crede ancora che qualche nostro soldato possa essersi rifatto una vita in Unione Sovietica durante e dopo la guerra. E’ una testimonianza estremamente cruda, e so che può fare molto male, ma rispecchia in parte ciò che è successo. Si prega di evitare commenti offensivi, Grazie.
 “Sono un russo che abita nella regione di Voronetz, dove voi italiani state cercando i resti dei soldati morti durante la guerra tra Unione Sovietica e la Germania, settanta anni fa. Vorrei aiutarvi perché sono stato testimone di ciò che è successo durante la vostra ritirata e conosco tante fosse dove i prigionieri italiani sono stati sepolti. Ce ne sono centinaia: quante siano esattamente nessuno lo sa e non lo saprà mai perché il tempo le ha cancellate.
“Sono un russo che abita nella regione di Voronetz, dove voi italiani state cercando i resti dei soldati morti durante la guerra tra Unione Sovietica e la Germania, settanta anni fa. Vorrei aiutarvi perché sono stato testimone di ciò che è successo durante la vostra ritirata e conosco tante fosse dove i prigionieri italiani sono stati sepolti. Ce ne sono centinaia: quante siano esattamente nessuno lo sa e non lo saprà mai perché il tempo le ha cancellate.
Quando è cominciata la guerra avevo dieci anni. Al momento degli avvenimenti che descrivo ne avevo dodici tredici e ricordo bene tutto. Vi parlo della distruzione di un centinaio, forse di centinaia di prigionieri italiani da parte di una scorta sovietica che li accompagnava. Tutti i vostri compatrioti sono stati annientati, fino all’ultimo, e gettati in un burrone. Ricordo e conosco perfettamente questa voragine: si trova nella federazione russa, regione di Voronetz, provincia di Vorobiovka, stazione Lescianaia, uliza Podlesnaia. Alla fine della via Podlesnaia attualmente vivono quattro famiglie: Jridnec, Nasalova, Volkov e Jolovanov. A cento metri da questa casa, subito oltre gli orti, si trova quel dirupo. A quel tempo l’abitato non si chiamava stazione Lescianaia, ma stazione Vorobiovka e c’erano venti o trenta case dove viveva molta gente. A quel tempo non esisteva neppure via Podlesnaia.
Il fosso era in un terreno abbandonato. La zona abitata vicino alla stazione Vorobiovka è cresciuta più tardi. Il burrone allora era coperto da pochi cespugli: ora non si può riconoscere perché è nascosto da un bosco piuttosto esteso. Io sono uno dei pochi testimoni di quella tragedia. A quei tempi, noi ragazzi vivevamo in miseria, eravamo seminudi e avevamo sempre fame. L’indigenza ci costringeva ad uscire nei giorni freddi d’inverno sulle strade dove le scorte russe continuavano a seguire colonne e colonne di prigionieri italiani.
Da noi non passavano né tedeschi né ungheresi, ma sempre italiani: li riconoscevamo subito per i cappotti verdi. Gli italiani avevano pin fame di noi: davano tutto quel the potevano per un pezzo di pane, per una patata o una mezza bietola. Cedevano fazzoletti da naso, l’ultima coperta, cravatte, uniformi e cappotti; insomma, tutto e andavano avanti semisvestiti anche se l’inverno era molto freddo. Vedevamo gli italiani che gelavano durante la marcia. I soldati di scorta facevano uscire dalla colonna quelli che non potevano pin andare avanti da soli, li portavano a cinque-sei metri dalla strada e li fucilavano.

Una slitta trainata da un cavallo che doveva servire per trasportare i prigionieri indeboliti accompagnava quasi sempre le colonne da un villaggio all’altro. Ma su queste slitte stavano sempre a turno i soldati di scorta. Cosi le file dei prigionieri andavano avanti lasciando per strada gli italiani fucilati. Sui fucilati, giovani a volte ancora vivi o appena feriti, si gettava subito una banda di noi, adolescenti e ragazzi dei villaggi. E due minuti dopo, il cadavere ancora caldo diventava nudo. Spesso si veniva alle mani accanto ai cadaveri, ognuno cercava di togliere per primo al morto tutto quel che capitava.
C’era fretta perché con quel freddo il cadavere gelava molto presto. Era impossibile togliere intatti stivali e vestiti a un cadavere gelato. In tali casi la popolazione locale, non più noi ragazzi ma gli adulti, ricorreva all’ascia. Di notte, quando nessuno li vedeva, gli uomini del villaggio andavano nei posti dove stavano i morti gelati. Per non distruggere il cappotto, la giubba e la camicia tagliavano le braccia al prigioniero. Poi tutto veniva sfilato dall’italiano congelato senza danneggiare le calzature. E di nuovo ricorrevano all’ascia. Tagliavano i piedi insieme alle calzature e li portavano a casa. Lì, al caldo, scongelavano i piedi, in tal modo le scarpe si toglievano bene. Poi gli uomini uscivano e andavano a sotterrare i resti lontano da casa.
Tutta la strada dalla città di Kalag, alla stazione Voriobvka, era piena di cadaveri dei prigionieri di guerra italiani. In alcuni posti per un tratto di cento metri si potevano contare anche nove corpi. I resti erano veramente molti, nessuno contava e se ne fregavano tutti; c’erano abituati. Ma poi è arrivata la primavera con il caldo, le salme hanno cominciato a decomporsi. E volente o nolente la gente ha cominciato a seppellirle vicino alla strada. Scavavano una fossa non profonda, vi gettavano il soldato e lo sotterravano alla meno peggio. Dopo la fine della guerra hanno cominciato ad arare la terra vicino alle strade per seminare. Durante l’aratura tiravano fuori dalla terra i resti degli italiani.
Per molti anni, teschi e ossa sono rimasti allo scoperto nei campi vicini alle strade e in fossati. Dietro agli orti e nei prati, lontano dalla strada dove passavano i prigionieri, giacevano le estremità inferiori. Tra la città di Kalag e la stazione di Voriobvka c’erano due abitati: il villaggio Novo-Tulugheevo e il villaggio Rudnia. In ogni villaggio c’era una chiesa. Tutte le chiese però erano semidistrutte e abbandonate, non c’erano vetri né riscaldamento. Di notte le scorte sistemavano i prigionieri italiani in questi templi.
Alla mattina molti erano congelati e altri lo erano per meta, ma per quanto ancora vivi non potevano alzarsi in piedi. I soldati di scorta accompagnavano fuori dalla chiesa chi poteva camminare e fucilavano quei prigionieri che non erano congelati del tutto, ma che non potevano muoversi da soli. Nessuno cercava di distinguere chi era congelato del tutto e chi no e quindi fucilavano spesso anche i vivi. C’era allora il problema di seppellire tutti quei morti. Proprio nel centro del villaggio, vicino  alla chiesa, si scavava una grande fossa comune. Su slitte si portavano dalla chiesa i cadaveri degli italiani e si gettavano dentro.
alla chiesa, si scavava una grande fossa comune. Su slitte si portavano dalla chiesa i cadaveri degli italiani e si gettavano dentro.
In mezzo a tanti caduti, come ho detto, c’erano anche italiani ancora vivi che cercavano di strisciare fuori dalla sepoltura comune, ma i soldati sovietici li finivano a calci, con le pale o semplicemente con palle di terra, li gettavano indietro nella fossa e poi sotterravano tutti insieme, i morti e i vivi. La sepoltura dei prigionieri era sempre accompagnata dal saccheggio. Nel villaggio Rudnia c’era un uomo, Lunin Kfarifon che non era andato alle armi perché malato mentale. Quando questi notava in bocca di un italiano, morto o vivo, un dente o una capsula d’oro, prendeva una pala o una pietra, spaccava la mascella ed estraeva l’oro.
E successo veramente di tutto in quei giorni, ma non c’era un censimento dei prigionieri italiani. La scorta spesso si dimenticava qualche congelato in fondo alla colonna, magari pensando che fosse morto. Ci sono stati molti casi di italiani rimasti indietro che si sono rifugiati nel villaggio, andando per le case, a riscaldarsi e chiedere cibo. Poi la scorta della successiva colonna li prendeva e li portava avanti.
Da noi c’è stata una storia con un italiano. Un prigioniero rimasto indietro rispetto ai suoi compagni. Le scorte non se lo sono preso. Lui e rimasto al villaggio. Ha girato un giorno intero e poi ancora per un altro giorno. Alcuni hanno avuto anche il coraggio di lasciarlo entrare per pernottare. Era un bel giovane e soprattutto era in grado di arrangiarsi. Sapeva riparare una serratura, rappezzare un secchio, spaccare legna e cucire gli stivali. Sapeva fare tutto. L’ospitò alla fine una vecchietta ed egli cominciò a vivere da lei, come un inquilino. La gente nel villaggio parlava spesso di questo “inquilino dell’Italia”. Gli abitanti cominciarono ad andare da lui con ordinazioni ed egli faceva tutto a tutti e riusciva a terminare tutte le commissioni. Cominciava a piacere agli uomini del villaggio.
Per il lavoro gli portavano quel che potevano, un pezzo di pane, patate, latte e altro cibo. L’italiano era diventato uno dei nostri simili, nel villaggio. Arrivò la primavera. Nel kolkos nessuno sapeva riparare ruote e carri. Il presidente del kolkos allora chiese l’aiuto dell’italiano. Anche in questo caso se la cavò bene, riparando tutto. Lavorava nel kolkos insieme a tutti gli uomini non chiamati alle armi per ragioni di salute; era stato addirittura nominato capo-brigata di falegnameria. Se qualcosa andava male negli affari del kolkos, il presidente diceva: “Va dall’italiano, lui sbroglierà la faccenda”. E l’italiano risolveva tutto.
Per esempio, nel mulino-oleificio per molto tempo non riuscivano ad avviare il diesel; il giovane mise a posto anche quello. Ma la dirigenza come poteva giustificare la permanenza illegittima di un prigioniero di guerra italiano nel villaggio? Semplice. Egli era amico del presidente del kolkos, perché lavorava bene. Inoltre, aveva cucito nuovi stivali al presidente del Soviet Rurale su sua richiesta. Non c’era nessun danno da parte del soldato, la gente si era abituata a lui e poteva vivere nel villaggio tranquillamente.
Cosi passarono circa due anni. Alla fine della guerra, quando le truppe hitleriane erano già state cacciate dal territorio dell’URSS, le autorità locali si ricordarono improvvisamente che nel loro villaggio viveva illegalmente, senza registrazione all’anagrafe, un prigioniero. A ricordarlo era stato un telegramma del reparto provinciale del NKVD, progenitore del KGB, che chiedeva notizie su quel prigioniero di guerra italiano vissuto per due anni nel villaggio. Non fu facile per le autorità locali spiegarne le ragioni.
Il presidente del Soviet Rurale e quello del kolkos cominciarono a scaricare la colpa l’uno sull’altro. Dopo molte discussioni non riuscirono a mettersi d’accordo e allora decisero di chiamare l’italiano al Soviet Rurale e l’uccisero con un fucile da caccia. La gente del villaggio ha sempre saputo chi ha premuto il grilletto: un certo personaggio che tutti chiamavano con il soprannome di «Gallo». La storia di quest’italiano, che ricordo benissimo, mi ha distratto dal tema principale. Ritrovare il burrone di quel massacro.
Chiarisco che su questa fossa non ci sono croci o pietre sepolcrali, né altro che possa farlo riconoscere. Solo io e pochi altri sappiamo del posto. Migliaia di corvi hanno volato sopra il burrone per tutta la primavera e tutta restate, fino all’autunno: perché quel mucchio di corpi umani si è trasformato presto in un mucchio di teschi, scheletri e ossa. Nessuno ha mai sotterrato i resti. Le acque di primavera li hanno dispersi nel dirupo per molti chilometri o li hanno portati via i cani. Forse alcune povere spoglie calcate dal tempo in fondo al ruscello, si trovano ancora là.
La sorte ha voluto che per cinque anni, dal 1957 al 1961, vivessi a cento metri dal burrone. Andando nel bosco per tagliare legna trovai molto spesso ossa umane, anche se tutti noi cercavamo di aggirare il posto. Quando vivevo vicino al burrone alcuni vecchi affermavano di sentire la notte gemiti e pianti. Altri sostenevano di vedere nel burrone luci simili a candele accese. Altri ancora raccontavano di ritrovarsi di notte scheletri umani vicino alle loro case. Un uomo di nome Miroshnicenko, che abitava proprio vicino al burrone, riuscì faticosamente a vendere la casa e a trasferirsi in un altro posto.
Conoscevo personalmente quest’uomo. Gli ho chiesto perché vendeva una bella casa e un buon terreno. Per molto tempo non mi ha risposto; poi una volta, davanti a una vodka, mi ha svelato il segreto. Miroshnicenko mi ha raccontato che non poteva vivere vicino al burrone perché quasi ogni notte, specie d’estate, lui e la sua famiglia sentivano lamenti e pianti. E se andavano alla finestra vedevano scheletri andare di qua e di là. Mi ha pregato di non raccontarlo a nessuno: temeva di non riuscire a vendere la casa.
Personalmente non ho sentito né visto certe cose nei cinque anni che ho vissuto vicino al burrone. Ma io stesso ho dovuto molte volte sotterrare i resti di prigionieri italiani. Avevo un grosso cane che liberavo ogni notte e che portava nella sua cuccia tutto quel che trovava. Quasi ogni mattina, vicino alla cuccia, trovavo un teschio umano o altre ossa. Prendevo queste spoglie, le portavo nel bosco e le sotterravo. La mattina dopo tutto si ripeteva. E cosi per molte mattine, finché ho capito che la situazione poteva durare in eterno. Allora ho venduto il cane. E non ne ho presi altri perché tutti i cani della zona andavano naturalmente in cerca di ossa the giacevano dappertutto nel villaggio: dietro gli orti, vicino alle strade, nei fossati.
Nel 1987, d’estate, sono tornato in ferie vicino al burrone, perché la vive ancora mia sorella. Andando a fare una passeggiata nel bosco, dopo tanti anni, sul fondo del ruscello ho visto ancora un teschio. Ma non vi ho raccontato com’è avvenuto il massacro. Era l’inverno del 1942 o del ’43, non ricordo bene; era sicuramente quasi buio. I soldati di scorta hanno portato vicino al burrone un’intera colonna di prigionieri italiani, centinaia. Poi li hanno cacciati dentro, sul fondo del burrone, stretti l’uno all’altro.
 Terminato questo lavoro, i soldati sovietici sono usciti dal dirupo e hanno cominciato a lanciare granate contro i prigionieri. C’erano molti soldati di scorta e tutti lanciavano granate, per un tempo abbastanza lungo. Negli intervalli tra le esplosioni delle granate si sentivano le grida dei condannati. Terminato il massacro i soldati di scorta sono scesi di nuovo sul fondo. Si sono sentiti spari, molti spari. Sebbene fossimo ragazzi noi capivamo bene cosa succedeva lì dentro: i sovietici stavano finendo i vivi con colpi di fucile e di baionetta. Poi i soldati di scorta sono saliti sui carri trainati da cavalli e sono partiti. Prima di cominciare il massacro, ci avevano cacciato via ma non molto lontano. Perciò noi abbiamo visto e sentito tutto.
Terminato questo lavoro, i soldati sovietici sono usciti dal dirupo e hanno cominciato a lanciare granate contro i prigionieri. C’erano molti soldati di scorta e tutti lanciavano granate, per un tempo abbastanza lungo. Negli intervalli tra le esplosioni delle granate si sentivano le grida dei condannati. Terminato il massacro i soldati di scorta sono scesi di nuovo sul fondo. Si sono sentiti spari, molti spari. Sebbene fossimo ragazzi noi capivamo bene cosa succedeva lì dentro: i sovietici stavano finendo i vivi con colpi di fucile e di baionetta. Poi i soldati di scorta sono saliti sui carri trainati da cavalli e sono partiti. Prima di cominciare il massacro, ci avevano cacciato via ma non molto lontano. Perciò noi abbiamo visto e sentito tutto.
Anche stavolta i soldati italiani non erano tutti morti. Sentivamo sospiri e gemiti. Sul fondo del burrone giaceva una montagna insanguinata di corpi. Anche la neve, per alcuni metri intorno, era inondata di sangue. I cadaveri giacevano con le viscere di fuori, senza testa e senza estremità. Teste, braccia, piedi e altre parti erano sparsi per molti metri intorno. E scesa la notte e il freddo ha finito quello che avevano lasciato in sospeso i soldati. Cosi sono scomparsi centinaia di italiani. Quella notte è nevicato e al mattino tutto era sepolto sotto uno strato spesso di neve. Non è un segreto per nessuno che nel burrone, ora nascosto da un bosco, ancora marciscano i resti di poveri prigionieri mai sepolti. Non è neanche un segreto che le ossa siano proprio italiane. Lo può confermare qualsiasi abitante della via Podlesnaia. Molti testimoni sono morti, come i miei amici Ivan Mikhailovic e Vasilj Popov che stavano accanto a me quella sera. Ma molti altri invece ancora vivono e ricordano. Ho già fatto i nomi e sono pronti a raccontare. Vi ho descritto tutto quello che ho visto con i miei occhi e sentito con le mie orecchie. Ciò che non riuscirò mai a spiegarvi è quel che ho sentito, e che sento, dentro di me”.
(Testimonianza presa dal giornalista-reporter di guerra Pino Scaccia)







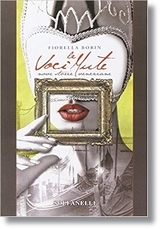






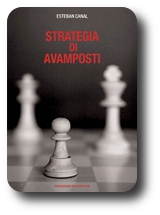


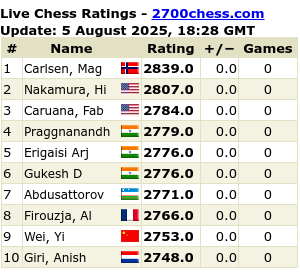

Ultimi commenti